 CURRÒ SALVATORE, Il dono e l’altro. In dialogo con Derrida, Lévinas e Marion, LAS, 2005
CURRÒ SALVATORE, Il dono e l’altro. In dialogo con Derrida, Lévinas e Marion, LAS, 2005
* * *
Introduzione
Il dono ha sempre a che fare con la trama delle relazioni sociali. Se qualcosa assume improvvisamente lo statuto di dono è perché entra nel circuito della relazione: un libro, una scatola di cioccolate, un oggetto semplicemente esistente diventa improvvisamente il mio dono all’altro o il dono dell’altro a me. E se il dono perde di significato o si trasforma addirittura da motivo di gioia in motivo di delusione è ancora per la sua connessione con la relazione, che si è incrinata o rovinata. La stessa relazione è avvertita come dono o a volte come smentita del dono. La fiducia ma anche la sfiducia nel dono si situano nella relazione con l’altro. Il dono, se ce n’è ma anche se non ce n’è, annuncia l’orizzonte relazionale o si annuncia nell’orizzonte relazionale. Da ciò il legame, evocato dal titolo di questa ricerca, tra il dono e l’altro. Ma il riferimento all’altro allude anche all’alterità del dono, e cioè al fatto che il dono proviene da altro. Non viene da me, anche quando fosse il mio dono all’altro. Posso donare parte del mio tempo a un amico, posso donare una mia moneta a un povero che mi obbliga a incrociare il suo sguardo; ma si tratta davvero del mio tempo e della mia moneta? A volte sento che l’altro a cui dono ha come dei diritti sul mio dono, che in realtà non mi appartiene. Nel dono si annuncia così qualcosa d’altro, un mondo altro rispetto al mio mondo. Il dono sa di novità, di sorpresa per me e anche per l’altro. Il dono mi sopraggiunge, mi rapporta a un già dato o già donato. Mi rapporta a ciò che non viene da me e che precede me: altro da me, che pure ha a che fare con me. Per questo l’alterità è l’orizzonte di questa ricerca sul dono.
Ma cosa vuol dire fare una ricerca sul dono? Non è questa una contraddizione? Il dono, a rigore, non si cerca ma sopraggiunge, non cercato e inaspettato. Non lo si definisce, non entra in un’idea, forse neanche in un discorso, perché in tal modo entrerebbe nella morsa di una presa, di una comprensione, e si annullerebbe immediatamente come dono. Eppure una ricerca sul dono è possibile a partire da un’idea e da una comprensione del dono, che orienta la ricerca stessa. Il rischio è però che alla fine la ricerca trovi quello che già in partenza possedeva; paradossalmente una ricerca sul dono, orientata a evidenziarne l’importanza e la centralità, potrebbe attestare alla fine, per il suo stesso cercare e senza accorgersene, proprio la negazione del dono[1]. A quali condizioni allora la ricerca può sfuggire alla trappola dell’annullamento del dono? In che modo può tenersi davvero aperta al dono? In che modo il già di comprensione del dono, che inevitabilmente agisce nella ricerca, può agire non come chiusura ma come trampolino di lancio per l’accoglienza del non ancora e dell’al di là della presa e della comprensione? La questione riguarda il modo stesso della ricerca.
A pensarci bene il rapporto tra il già e il non ancora non necessariamente deve risolversi a vantaggio o nella prospettiva del già. L’al di là del dono, di più rispetto alla comprensione del dono, non necessariamente dev’essere ricondotto alla portata di un pensiero catturante, che in fondo non sopporta la novità e che perciò deve commisurarla a sé. Nel già del dono si aprono delle fessure. Il di più del dono non si fa presente al pensiero ma, sottraendosi, provoca il pensiero ad uscire da sé, lo altera, rompe la monotona uguaglianza tra il presente e l’essere presente al pensiero. Il presente è più che presente[2]. Afferma Martin Heidegger: «Ciò che a noi in questo modo si sottrae, si allontana da noi. Ma, proprio in tal modo, ci porta con sé e ci attrae a suo modo verso di sé. […] Quello che si sottrae è presente (west an), e ciò nel senso che ci attrae, sia che noi in generale ce ne accorgiamo oppure non. Quel che ci attrae ha già concesso il suo avvento. Quando noi perveniamo nel trarre (Ziehen) del sottrarre (Entzug), siamo già in marcia (auf dem Zug) verso ciò che ci attrae in quanto si sottrae»[3].
Il pensiero così non semplicemente riconosce la differenza del di più del dono ma si articola come differenza. Si apre la possibilità che si sprigioni la forza di appello (e di dono) del dono. Osserva ancora Heidegger: «Proprio alle parole essenziali di una lingua accade che ciò che esse propriamente dicono cada facilmente nell’oblio, facendo posto al significato che si impone più immediatamente. Il mistero di questo processo, l’uomo non lo ha ancora pensato. Il linguaggio sottrae all’uomo il proprio parlare semplice e alto. Ma in tal modo il suo appello principale non diventa muto, solo rimane silenzioso. È vero che l’uomo tralascia di fare attenzione a questo silenzio»[4]. La parola che dice il dono dovrà allora lasciare che il dono si dica. Sarà una parola continuamente interrotta dal silenzio, cioè dall’appello; parola che parla per far parlare il dono. Parola preparatoria, che assomiglia al lavoro di dissodamento di un campo; parola segnata come da un presentimento o da una lontana e sbiadita memoria di un dono nascosto nel campo. Parola che introduce al dono, perché forse del dono si può scrivere solo un’introduzione.
O forse la parola stessa può farsi dono? Ma a quali condizioni? E in quale misura? La condizione è che la parola sia già risposta all’appello del dono e che sia quindi parola responsoriale, segnata radicalmente dalla responsabilità e dalla riconoscenza. Non parola che esprime la risposta e il ringraziamento ma parola-che-risponde e allo stesso tempo parola-riconoscente. Parola espropriata di ogni potere, non più veicolo di idee, non più parola metafisica. Una tale parola non può che essere una parola situata in un orizzonte di alterità: parola detta all’altro e parola che viene da altro; parola che dice più di quello che dice, che dice altro di quello che dice, parola che non appartiene né a chi parla né a chi ascolta, né allo scrittore né al lettore. Parola che obbedisce più che descrivere. Parola altra. Ma scrivere sul dono significa inevitabilmente dire una parola propria, significa prendere la parola, interpretare il dono. E la presa di posizione contraddice necessariamente il dono, perché se ne appropria. Ma questa appropriazione o presa di coscienza del dono è necessaria, a condizione forse che abbia ultimamente lo statuto di un racconto di dono. Il dono infatti precede la parola e la parola è in definitiva testimonianza o parola di grazia ricevuta. Ma la condizione è anche che il racconto non sia troppo lungo e che la parola sia sovente interrotta o che si lasci sospendere. La parola vive del silenzio o dell’accoglienza del dono, che è più che linguaggio. La parola sul dono ha bisogno delle interruzioni della responsabilità. Il dono si fa prima di tutto. E questo fare, orizzonte di alterità del pensiero o concretezza prima e oltre il pensiero, è il vero luogo ermeneutico del pensiero. Afferma Emmanuel Lévinas: «Solo nella generosità il mondo posseduto da me – mondo offerto al godimento – può essere scoperto da un punto di vista indipendente dalla posizione egoistica. […] La presenza d’Altri (Autrui) equivale a questa messa in questione del mio indisturbato possesso del mondo»[5].
Perché il senso del dono si dica la ricerca deve dunque impegnarsi su tre livelli: in primo luogo, essa dice la presa di coscienza (o il già) del dono; ma, in secondo luogo, si lascia anche disdire dall’appello del non ancora del dono; infine, essa si situa nella responsabilità del dono, come ottica ermeneutica (o più che ermeneutica) privilegiata. I tre livelli si intersecano, ma il terzo, che si sporge oltre il pensare, dà il tono a tutta la ricerca. Il dono è infatti prima di tutto responsabilità. La ricerca sul dono è in definitiva la ricerca delle condizioni perché il dono, se ce n’è, si dia; o, più precisamente, è la ricerca di tutto ciò che è in potere del soggetto perché ci sia dono. Il dono, che pure si sottrae assolutamente all’iniziativa del soggetto (e quindi non è nelle sue possibilità) non si dà però senza il soggetto. Solo se il soggetto risponde al dono o solo nel soggetto-responsabile-del-dono si dà dono. La risposta al dono in certo senso precede il dono. E nella risposta al dono si modifica radicalmente lo statuto stesso della soggettività. Il soggetto-che-cerca-il-dono si rovescia nel responsabile-del-dono, che mentre risponde comprende, mentre dona riceve il dono o si riceve in dono. Il pensiero così – nei due livelli del racconto del già e dell’apertura al non ancora – deborda nel più-che-pensiero, nella responsabilità più che ermeneutica e che pure è luogo ermeneutico del dono. Lo sguardo fenomenologico subisce qui come una curvatura improvvisa. Il dono, che pure si dà al pensiero intenzionale, non soltanto lo deborda ma rinvia al luogo di responsabilità (o di irresponsabilità) del pensare, rinvia al più e meglio che pensare. Semplicemente perché donare e accogliere un dono è più e meglio che pensare, ma è anche il luogo in cui acquista senso il pensare[6].
Con ciò si è aperto un sentiero; uno dei possibili sentieri del dono ma allo stesso tempo quello proprio ed unico di questa ricerca. Stando ad Heidegger infatti pensare vuol dire percorrere un sentiero e uno solo (perché a un pensatore compete un solo sentiero), e vuol dire percorrerlo in un costante andirivieni, sentendolo come il proprio pur senza potersene appropriare[7]. Percorrerò dunque il sentiero della responsabilità del dono, passando per sei snodi ma attraverso un andirivieni che riprende continuamente il senso del cammino e che rinvia ogni presa di coscienza all’al di là della presa e al dono, sempre più che coscienza del dono. I sei snodi corrispondono ai sei capitoli della ricerca:
-
Il dono si situa nel circuito delle relazioni umane e nella concretezza dello scambio economico; sembra connesso alla reciprocità delle relazioni, alla coscienza del dare e avere, come anche alla coscienza di una finalità da raggiungere. Ma nelle relazioni subentra un’istanza di gratuità, che va oltre la reciprocità e la coscienza, che mette in scacco ciò che sembrava dono e che suscita il timore dell’impossibilità del dono.
-
Il dono sembrerebbe impossibile o forse, più positivamente, l’impossibile che dà senso al possibile e che significa come un ordine che entra prorompente nella coscienza senza lasciarsi catturare; e tale ordine sembra comunque manifestarsi particolarmente nella relazione con l’altro.
-
Si apre così lo spazio del dono, nel cuore della relazione ma oltre la relazione. Va esaminata quella particolare situazione relazionale in cui l’io, di fronte all’altro, non è più nella coscienza del dare e avere (reciprocità) ma è come costretto a rispondere, costretto a donare. In questo spazio asimmetrico il soggetto si scopre responsabile prima che (o più che) colui che può scegliere di dare o non dare; si ritrova spiazzato o sconvolto in quanto io; si scopre come senza fondamento o senza cominciamento in sé. Lo spazio che si apre ha allo stesso tempo un significato etico e di infinito.
-
Ma la costrizione a donare è solo risposta all’appello dell’altro o riposa anche sulla coscienza del dono? In realtà il dono sembra segnare ogni fenomeno, ogni esperienza di vita; il soggetto stesso sembrerebbe attraversato da cima a fondo dal dono, vive di dono, si riceve in dono. È l’alterità la condizione del dono o piuttosto il dono la condizione dell’alterità?
-
L’apertura al dono non può che essere dalla prospettiva della responsabilità e cioè del soggetto interpellato, che rompe con la stessa coscienza e ricerca del dono. Ma la radicalizzazione della responsabilità dell’eccomi, l’assoggettamento all’altro, si producono in definitiva grazie ad altri e nello spazio infinito di un ricevere (o un accogliere) mentre si dà. Il dono emerge, dall’al di là della coscienza, come l’altra faccia della responsabilità.
-
Il soggetto, o meglio l’assoggettato-all’altro e il riceventesi-incessantemente-in-dono, si trova continuamente all’incrocio tra il dono e l’appropriazione del dono, tra la gratuità e il calcolo della reciprocità, tra la radicalità del dono e le esigenze di uguaglianza della società e della politica, tra la responsabilità di fronte alla legge e la responsabilità illimitata. Il suo compito di salvaguardare il dono passa per la decisione, sempre da rinnovare, di aprire, nella monotonia del tutto uguale e dell’equilibrio degli egoismi, gli spazi (etici e di infinito) che permettono il sopraggiungere del dono. Si tratta di imparare a dire il dono o di apprendere il dirsi del dono; o, più radicalmente, si tratta di farsi traccia o parola del dirsi del dono: dono del dono.
Il sentiero tracciato è uno e peculiare, ma non sarà percorso in solitudine. Percorrere un sentiero significa incrociare altri sentieri e soprattutto imbattersi in altri viandanti, fare qualche tratto di strada insieme, confrontarsi e magari, dopo aver sentito la ricchezza del contatto, riprendere di nuovo le distanze. Diversi autori si sono imbattuti nel dono e si sono messi sulle sue tracce. Non tanto nel senso che nella loro opera il tema del dono abbia più spazio rispetto ad altri temi; ma piuttosto nel senso che nel loro pensiero il dono porta (e nasconde allo stesso tempo) il richiamo di un nuovo modo e di una nuova possibilità di pensare. Il riferimento è ad autori che si muovono nel solco della fine della metafisica, annunciata da Nietzsche e ritematizzata da Heidegger. In concreto, farò qualche tratto di strada insieme, e nel confronto, in particolare (ma non esclusivamente) con Jacques Derrida, Emmanuel Lévinas e Jean-Luc Marion. Questi tre pensatori hanno molti elementi di comunanza: l’appartenenza alla tradizione culturale francese; l’agire in essi, come fonte di ispirazione e sia pure con un peso e un significato diversi, della tradizione ebraica o ebraico-cristiana; la formazione fenomenologica e allo stesso tempo la sensazione (anche qui comunque con notevoli diversità) di dover allargare l’orizzonte della fenomenologia, ma in nome o dall’interno della fenomenologia stessa; la necessità di confrontarsi particolarmente con l’eredità del pensiero heideggeriano.
Ma le differenze non sono da meno dei punti di incrocio. E, come si sa, talvolta sono le sfumature a fare la differenza. Di fatto i percorsi di Derrida, Lévinas e Marion presentano ciascuno una forte originalità e una peculiare prospettiva sul dono. Semplificando un po’ e dall’ottica con cui ho attivato il confronto in questa ricerca, si può dire quanto segue. Derrida ci avverte sull’impossibilità del dono o, più precisamente, sull’impossibilità che il dono, se ce n’è, entri nei processi di appropriazione della coscienza; è piuttosto la coscienza provocata a lasciarsi sconvolgere, ad uscire nel mare aperto, ad obbedire, ad accogliere. Lévinas ci pone innanzi il primato dell’etica, cioè della relazione con l’altro a partire dall’altro: il dono è innanzitutto l’offerta del mio dono all’altro che mi interpella e mi spodesta; al di fuori dell’etica (di un’etica al di là dell’essere e prima di ogni diritto d’essere) sarebbe illusorio parlare di dono. Marion è, tra i tre, colui che più espressamente parla di dono e di donazione; afferma a chiare lettere il primato della donazione, ricomprendendo ogni fenomeno e il soggetto stesso in chiave di dono; il dono diventa persino chiave di ripensamento di tutta la fenomenologia, che nel suo senso più radicale non può essere che fenomenologia della donazione. Non nascondo che un tratto più lungo di strada lo percorrerò in compagnia, e in confronto critico allo stesso tempo, con Lévinas. La sua filosofia dell’alterità radicale e dell’etica al di là dell’essere offre, a mio modo di vedere, l’orizzonte più consono a una ricerca sul dono; essa apre all’accoglienza e alla comprensione del dono. È pure vero però che la prospettiva del dono, di per sé non molto tematizzata da Lévinas, offre una chiave di ricomprensione e, oserei dire, di umanizzazione o di fattibilità della stessa etica levinassiana. Ma sarebbe insensato parlare di correttivi. A ognuno il suo percorso.
* * *
Note
[1] È l’obiezione che Jacques Derrida muove al Saggio sul dono di Marcel Mauss, di cui si potrebbe affermare che «parla di tutto tranne che del dono» (Donare il tempo. La moneta falsa, tr. di G. Berto, Cortina, Milano, 1996, 26).
[2] La lingua italiana, nella quale il dono si dice anche presente, permette questo gioco di parole.
[3] Che cosa significa pensare?, in Saggi e discorsi, a cura di G. Vattimo, Mursia, Milano, 1976, 89.
[4] Costruire abitare pensare, in ibid., 98.
[5] Totalità e Infinito. Saggio sull’esteriorità, con un testo introduttivo di S. Petrosino, tr. di A. dell’Asta, Jaca Book, Milano, 1990, 73-74.
[6] Ciò non vuol dire che la ricerca sul dono debba abbandonare il metodo fenomenologico. Il fatto è che il dono mette a dura prova l’orizzonte della fenomenologia, a mio parere più che contestandolo situandolo. In questo senso ha ragione Silvano Petrosino ad assumere con prudenza l’espressione fenomenologia del dono. Tale espressione «non è forse del tutto adeguata al nostro oggetto; certo, in qualche modo ogni descrizione dell’atto del donare è e non può che essere una fenomenologia, eppure in senso rigoroso quest’ultima non può mai costituirsi fino in fondo dato che il dono – ecco il punto essenziale – non appare mai come tale, non si impone mai come dono». E ancora: «in effetti affinché il dono appaia come tale è necessario ch’esso venga accolto come dono in quell’orizzonte di libertà all’interno del quale l’evidenza stessa emerge sempre come appartenente all’ordine dell’accoglienza. Di conseguenza – ed è questo, forse, il tratto essenziale di ogni autentica fenomenologia del dono – l’evidenza del dono appare e diviene evidente solo all’interno di un pre-atteggiamento di dono che in qualche modo precede sempre l’atto stesso del donare. […] Non c’è dono senza accoglienza del dono, e l’atto del donare non è mai separabile da quella capacità/libertà che fa del ricevere ultimamente un accogliere» (Il figlio ovvero Del padre. Sul dono ricevuto, in GILBERT P. – PETROSINO S., Il dono. Un’interpretazione filosofica, Il Melangolo, Genova, 2001, 74).
[7] La sentenza di Nietzsche «Dio è morto», in Sentieri interrotti, pres. e tr. di P. Chiodi, La Nuova Italia, Firenze, 1986, 193.
 ROMANO ANTONINO, Les catéchistes á Madagascar. Rapport sur la formation et la vie des Catéchistes (Enquête 2004-2006), Coop.S.Tommaso, 2006
ROMANO ANTONINO, Les catéchistes á Madagascar. Rapport sur la formation et la vie des Catéchistes (Enquête 2004-2006), Coop.S.Tommaso, 2006
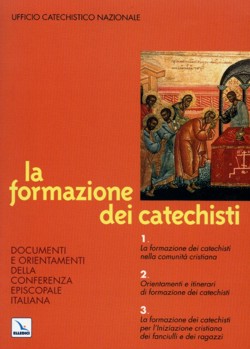 UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE, La formazione dei catechisti, Elledici, 2006
UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE, La formazione dei catechisti, Elledici, 2006 PIO ZUPPA – SANDRO RAMIREZ (a cura di), Autobiografia e formazione ecclesiale, Edizioni Viverein, 2006
PIO ZUPPA – SANDRO RAMIREZ (a cura di), Autobiografia e formazione ecclesiale, Edizioni Viverein, 2006 BARBETTA SALVATORE, Rievangelizzare gli adolescenti. Una comunità che progetta il cammino umano-cristiano degli adolescenti, Elledici, 2005
BARBETTA SALVATORE, Rievangelizzare gli adolescenti. Una comunità che progetta il cammino umano-cristiano degli adolescenti, Elledici, 2005 CURRÒ SALVATORE, Il dono e l’altro. In dialogo con Derrida, Lévinas e Marion, LAS, 2005
CURRÒ SALVATORE, Il dono e l’altro. In dialogo con Derrida, Lévinas e Marion, LAS, 2005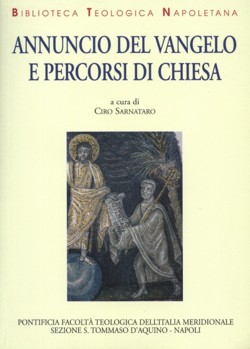 SARNATARO CIRO, Annuncio del Vangelo e percorsi di Chiesa. Le vie della povertà, dell’alterità e della bellezza, Biblioteca Teologica Napoletana, 2005
SARNATARO CIRO, Annuncio del Vangelo e percorsi di Chiesa. Le vie della povertà, dell’alterità e della bellezza, Biblioteca Teologica Napoletana, 2005